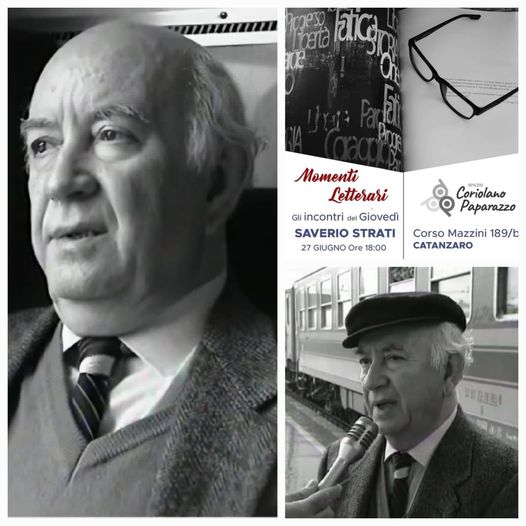Forte della recente vittoria dell’Oscar come migliore attore a Brendan Fraser, il protagonista, anche il Nuovo Supercinema di Catanzaro proietta in questi giorni il film più discusso del momento, campione di incassi al botteghino, “The whale” di Darren Aronofsky. La pellicola racconta di un professore alle prese con una grave obesità che lo limita nei suoi rapporti con il resto del mondo. Comprendiamo fin dalle prime immagini del film che il suo passato è costellato di dolori: dalla fine del proprio matrimonio, alla mancanza di un rapporto vero con la figlia (la purtroppo sottovalutata Sadie Sink di “Stranger things”), alla perdita del suo ex compagno, che già gli era stato allontanato da una chiesa ortodossa che cerca, adesso, attraverso un giovane missionario, di accoglierlo nonostante i suoi rifiuti.
Da qui il suo voluto isolamento, aggravato dalle difficoltà fisiche che questo corpo ingombrante gli impone – o si autoimpone. Il film, del resto, è un continuo scandagliare il dolore, l’emarginazione e l’impossibilità – vera o indotta – a rapportarsi con gli altri: i commenti di chi The whale l’ha già visto sono piuttosto comuni e frutto di emozioni forti. Il pubblico si è diviso in due: c’è chi lo ha trovato commovente e chi invece disturbante, senza alcuno spiraglio positivo.
Aronofsky è il regista de “Il cigno nero”, “The wrestler”, ma anche del discussissimo “Mother!”. Rispetto a quest’ultima pellicola, con protagonista Jennifer Lawrence, qui il regista newyorchese attua un’operazione diametralmente opposta: se in Mother! chiamava direttamente in causa la preparazione dello spettatore, invitandolo a comprendere significati nascosti che andavano ben oltre ciò che scorreva sullo schermo, in questo The whale non chiede altro che una partecipazione emotiva. Nel film, tratto dall’omonimo lavoro teatrale di Samuel D. Hunter, Aronofsky mostra tutto, in maniera ossessiva, sicuramente grottesca e crudele. Invece che al suo intelletto punta direttamente alla pancia di chi guarda – e non è un gioco di parole, oltre a essere facile facile -: qualcuno lo ha definito quasi pornografico, di certo è un film che indugia sulle difficoltà a muoversi e vivere quotidianamente di questo corpo disgustoso e ingestibile, di cui vergognarsi, con una latente rabbia per Charlie che sa bene a cosa va incontro ma non fa nulla per cambiare il proprio destino, se non seminare americanamente amore. Come nelle puntate di “Vite al limite”, mentre ti aspetti che arrivi da un momento all’altro il dottor Nowzaradan - spauracchio di ogni obeso -, si danno per assodati luoghi comuni: il trangugiare meccanicamente senza sosta – rivelazione: gli obesi non mangiano proprio così -, la difficoltà di reagire a un lutto, l’incomunicabilità di chi paradossalmente lavora con le parole, il parallelo con il capolavoro di Melville, Moby Dick (chiamatemi pure Ismaele, ma chiaritemi, se non per il termine “balena”, cosa c’entra). Charlie è un reietto - la cupezza claustrofobica degli interni in cui è quasi esclusivamente girato il film lo conferma -, e l’obesità, come qualsiasi altra “dipendenza” dovrebbe essere solo un sintomo di una situazione che va ben oltre la questione fisica, ma siamo sicuri che sia un passaggio chiaro? Il dubbio c’è, sottolineato dall’indugiare della telecamera su ogni difficoltà di movimento, con lunghi piani sequenza, che scandisce questa lenta agonia. In quest’ottica anche l’Oscar a Fraser suona come americanamente politicamente corretto.
(Multi Cunti per Area Teatro Catanzaro Centro)